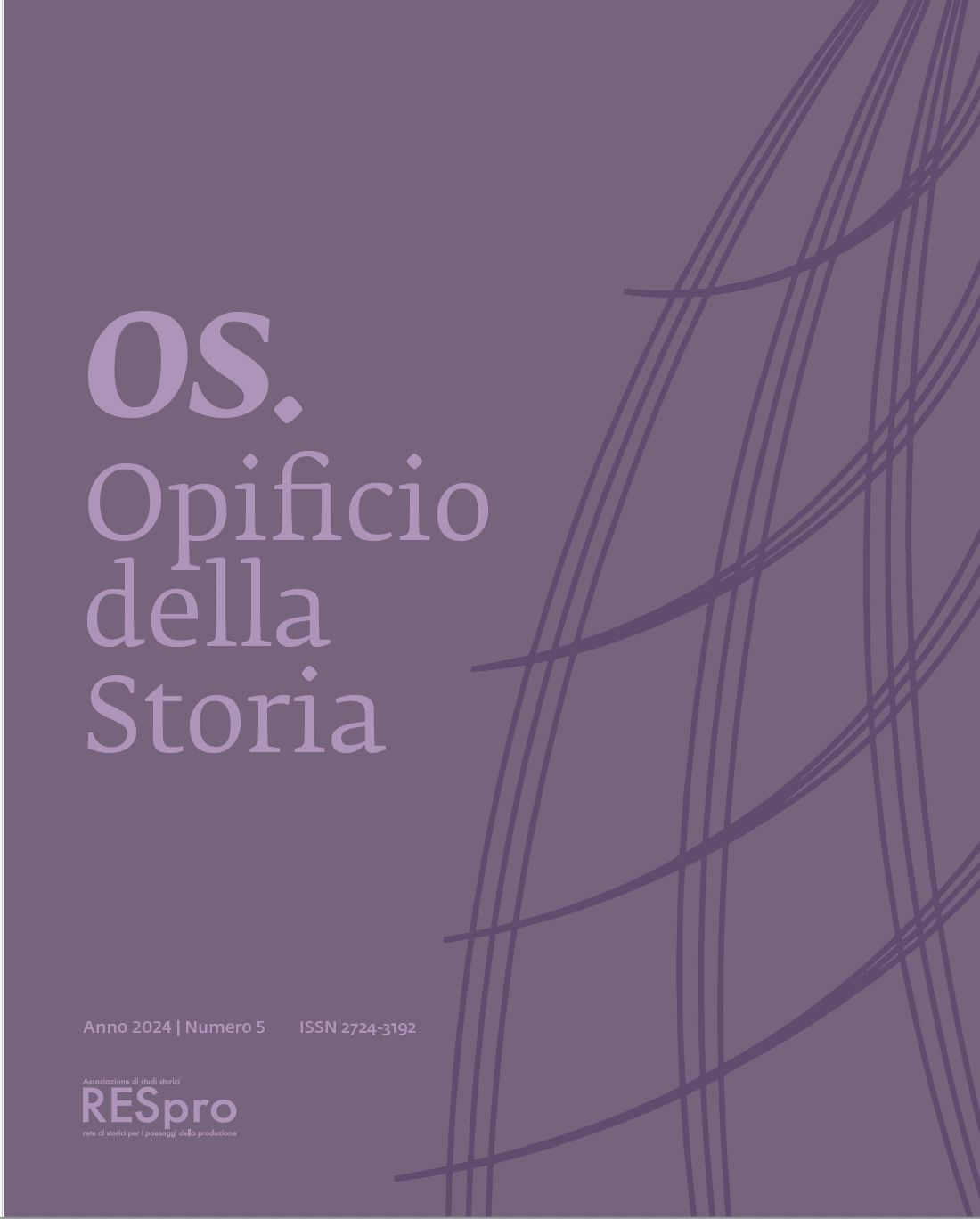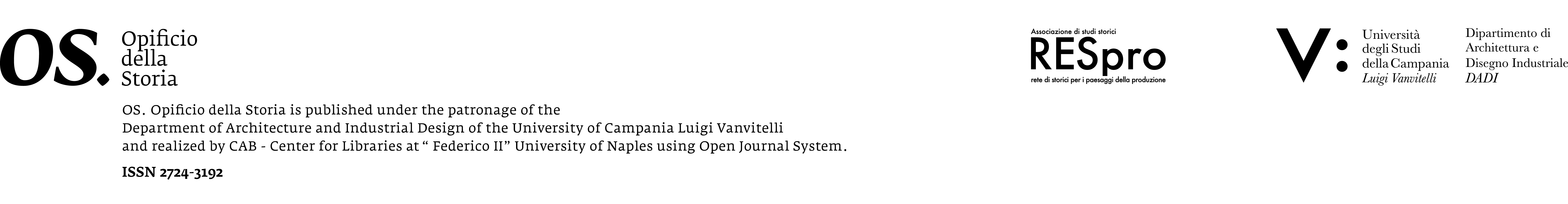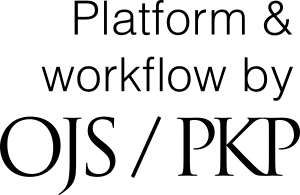L’Archeologia industriale: quale futuro in Francia?
DOI:
https://doi.org/10.6093/2724-3192/11649Parole chiave:
Patrimonio industriale, Francia, Unesco, Adattamenti di abitazioni storiche, MuseiAbstract
L'archeologia industriale, emersa negli anni '60, si è affermata come disciplina autonoma, influenzando iniziative innovative sul patrimonio e contribuendo allo sviluppo del patrimonio industriale. Questa disciplina ha un impatto culturale tangibile e affronta questioni controverse legate al capitalismo e all'impresa, in particolare per le implicazioni sociali e culturali.
In Francia, l'archeologia industriale è emersa negli anni '70, principalmente all'interno di associazioni e musei, ma anche nell'ambito dell'istruzione superiore e della ricerca. Maurice Daumas ha avviato una riflessione su questo tema, seguito da Bertrand Gilles e Denis Woronoff, che hanno definito l'archeologia industriale come lo studio del legame tra la produzione e il luogo di produzione. Questa disciplina si occupa di edifici, infrastrutture e dei loro elementi materiali, umani e astratti, richiedendo l'osservazione, lo scavo e l'analisi di fonti scritte, iconografiche e orali.
Il patrimonio industriale è un costrutto sociale che implica la protezione di oggetti materiali o astratti secondo criteri estetici, storici, politici, religiosi, sociali o tecnologici. Include non solo i siti produttivi, ma anche le infrastrutture sociali, economiche, culturali, religiose o sportive. La complessità del patrimonio industriale ha portato alla creazione di un dipartimento specifico all'interno del Ministero della Cultura francese nel 1983.
Dalla fine del XX secolo, la ricerca si è estesa oltre il periodo della prima industrializzazione, includendo siti ancora in funzione, come stazioni ferroviarie e aeroporti. Alcune aree, come il bacino minerario del Nord-Pas-de-Calais e le colline, le case e le cantine della Champagne, sono state riconosciute come patrimonio mondiale dell'Unesco, integrando la conservazione del patrimonio con le attività economiche locali.
L'inclusione nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco ha promosso lo sviluppo del patrimonio industriale in Francia, ma ha anche generato tensioni legate al turismo di massa e alla sostenibilità dei siti. L'adattamento di abitazioni storiche, come quelle dei lavoratori, solleva dilemmi tra il rispetto del significato storico e culturale e l'adattamento alle esigenze moderne e ai cambiamenti climatici. Esempi di ristrutturazioni efficaci dimostrano che è possibile migliorare l'efficienza energetica senza compromettere l'estetica esterna. La conservazione del software e del codice sorgente come nuovi oggetti tecnologici immateriali rappresenta una sfida. Il patrimonio contestato, come l'industria coloniale e l'impatto ambientale delle attività industriali, richiede ulteriori studi. Le difficoltà di conservazione del patrimonio legato ad attività inquinanti e pericolose sono evidenti, come dimostra la controversia sul laboratorio di Marie Curie a Parigi.
I musei tecnologici, nati dall'interesse per il patrimonio industriale, svolgono un ruolo importante nella trasmissione delle conoscenze tecnologiche e artigianali. Alcuni musei ospitano collezioni preziose e offrono formazione per perpetuare le competenze nel settore.
In conclusione, il patrimonio industriale è diventato un campo disciplinare molto attivo, con significative ripercussioni sull'economia e sulle strategie territoriali, oltre a rappresentare un'importante sfida per la ricerca futura.