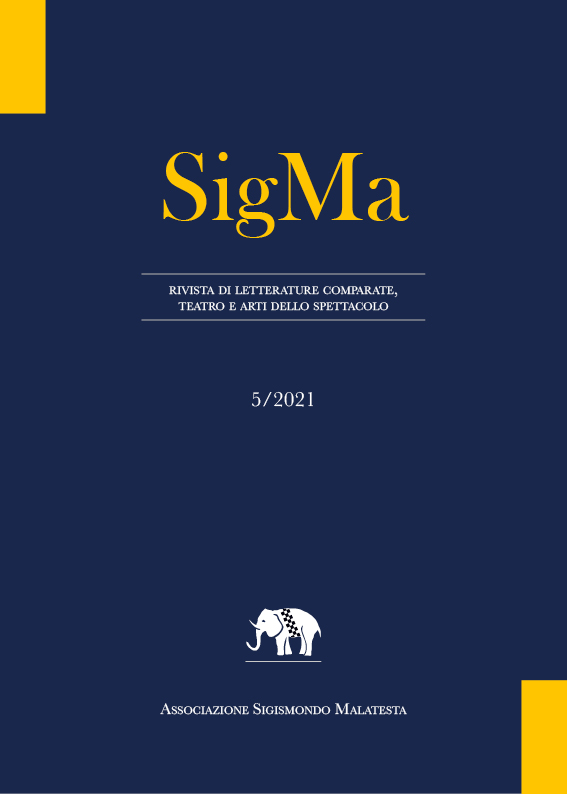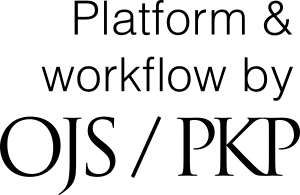La macchina mitologica della venezianità. Retorica barocca e imperialismo fascista
DOI:
https://doi.org/10.6093/sigma.v0i5.8768Abstract
L’articolo mette in comunicazione due paradigmi critici, l’uno teorico e l’altro storiografico: da una parte il modello della macchina mitologica elaborato da Furio Jesi, dall’altra l’ideologia della venezianità studiata, in relazione al Ventennio fascista, da Mario Isnenghi. Le proiezioni mitologiche della Serenissima vengono alimentate, nel primo Novecento, dalle opere di Gabriele D’Annunzio e, più in generale, dal dannunzianesimo cinematografico, di cui si indaga qui un caso specifico (La nave, 1921); ma la ripresa, a fini propagandistici, del mito di Venezia è un fenomeno trasversale, che interessa tanto le riviste patinate quanto gli studi storici, garantendo un paludamento retorico agli interessi, finanziari e militaristi, della nuova borghesia in ascesa. Adoperando gli strumenti concettuali approntati da Jesi, l’articolo si impegna a sciogliere questa mitologia in senso diacronico. Si delinea così una variante specifica del mito di Venezia, le cui fonti non appartengono alla più celebre vulgata cinquecentesca, ma risalgono invece alla seconda metà del Seicento, quando le guerre contro i Turchi favoriscono, tanto nelle celebrazioni pubbliche quanto in tipografia, l’emergere di una retorica bellicosa e individualista. Le idee e le narrazioni germinate in epoca barocca, come pure i nomi dei dogi e dei capitani che di quella stagione furono i maggiori interpreti, si ritrovano puntualmente sia nell’intensa attività pubblicistica di Gino Damerini, uno dei più importanti intellettuali della Venezia fascista, sia nei versi con cui D’Annunzio celebra la guerra di Libia (Merope, 1912).
Downloads
Downloads
Pubblicato
Come citare
Fascicolo
Sezione
Licenza
SigMa pubblica in internet, ad accesso aperto, con licenza:
|
|
CCPL Creative Commons Attribuzione |
L'autore conserva il copyright sul suo contributo, consentendo tuttavia a chiunque "di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare l'opera", purché siano correttamente citati l'autore e il titolo della rivista. L’autore, al momento della proposta di pubblicazione, è inoltre tenuto a dichiarare che il contenuto e l’organizzazione dell’opera è originale e non compromette in alcun modo i diritti di terzi, né gli obblighi connessi alla salvaguardia di diritti morali ed economici di altri autori o di altri aventi diritto, sia per testi, immagini, foto, tabelle, sia per altre parti di cui il contributo può essere composto. L’autore dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali per l’ipotesi di falsità in atti ed uso di atti falsi, e che pertanto Reti Medievali è esente da qualsiasi responsabilità di qualsivoglia natura, civile, amministrativa o penale, e sarà dall'autore tenuta indenne da qualsiasi richiesta o rivendicazione da parte di terzi.