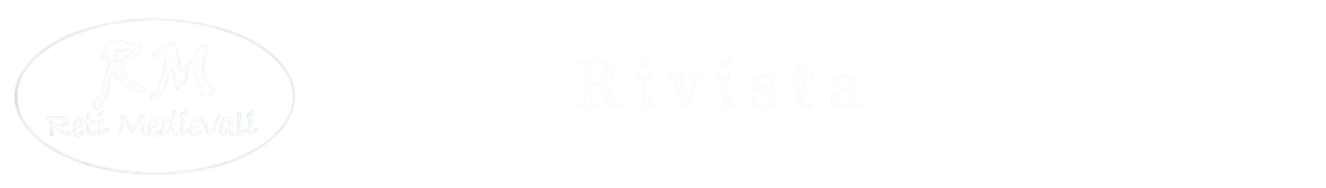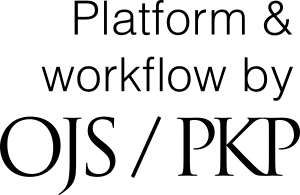Costruire territori/costruire identità. Lagune archeologiche a confronto tra antichità e medioevo
DOI:
https://doi.org/10.6092/1593-2214/476Parole chiave:
Late Antiquity, Middle Ages, 1st-10th Century, Veneto, Po Delta, Adriatic See, Archaeology, Settlements, Lagoon, TerritoryAbstract
L’idea di organizzare questa raccolta di studi nasce dal desiderio di mettere a confronto alcune esperienze maturate nell’ambito delle ricerche archeologiche che l’Insegnamento di Archeologia Medievale dell’Università Ca’ Foscari sta conducendo, da tempo, su due lagune dell’arco adriatico settentrionale. Tali ricerche hanno preso, nel corso del tempo, strade sempre più divergenti dall’argomento iniziale. Inoltre, si è constatato come l’uso delle fonti diventasse esso stesso soggetto di discussione e passaggio fondamentale per la formulazione di un’archeologia dotata di un qualche senso. Dunque, in questo contesto si è lavorato su quelle possiamo definire “fonti archeologiche tradizionali”, cioè sui dati materiali noti, ma si sono tentate anche altre vie, riconoscendo o meglio costruendo fonti archeologiche in parte nuove, che fossero in grado di amplificare le potenzialità euristiche della documentazione a disposizione.
Le lagune comparate sono due, quella di Venezia e quella di Comacchio. Due contesti paleo-ambientali (in parte simili ma non uguali) che hanno prodotto, tra tarda-antichità e alto-medioevo, due importanti episodi di nuovi insediamenti. I processi attraverso i quali si è arrivati alla realizzazione di due esperienze urbane compiute (quelle di Comacchio e di Venezia, appunto) sono stati variamente analizzati e spiegati dalla storiografia tradizionale, anche se spesso si sono privilegiate lettura meccaniche di tipo migrazionistico (per quanto di limitata dimensione). In realtà, lo studio dell’ambiente e delle sue trasformazioni (contributo Corrò, Moine, Primon su Sant’Ilario e Rucco su Comacchio) e l’analisi di comunità emergenti in competizione (contributo Cadamuro, Cianciosi, Negrelli su Jesolo e Cittanova e Grandi su Comacchio), dimostrano in maniera inequivocabile come tali processi siano stati estremamente articolati, diversificati nel tempo, fortemente legati anche al rapporto con l’ambiente, con la proprietà terriera, con la vocazione commerciale oltre che con le diverse opportunità politiche.
In questa sezione quattro casi, da tempo ‘sotto osservazione’ vengono analizzati e spiegati. Nel caso del monastero di Sant’Ilario e Benedetto di Gambarare (Mira), la storia del cenobio (legato alla famiglia comitale dei Partecipazi) viene intrecciata con quella del territorio e delle sue risorse, grazie ad un innovativo approccio geo-archeologico. Il sito di Jesolo, l’antiqua Equilum, e della vicina Cittanova, vengono affrontati tenendo conto sia delle indagini di carattere territoriale, che degli importanti risultati delle nuove campagne di scavo. L’episodio di Comacchio, invece, oggetto di studi da diversi anni, viene analizzato da una duplice prospettiva: quella più ‘tradizionale’ della formazione dell’abitato (grazie anche ai risultati delle recenti campagne di scavo), e quella meno scontata della ricostruzione del paleo ambiente, funzionale ad una migliore comprensione delle connessioni del sito ma anche del suo rapporto con le sue risorse disponibili.
Nel complesso ne emerge un quadro che, pur nella frammentazione e nella specifica identità dei singoli contributi, si muove verso la costruzione di un unitario paradigma interpretativo, dove il territorio costruito è analizzato in tutte le sue forme ed espressioni, materiali ed ideologiche. Ne consegue la storia originale, e per certi versi unica, di un segmento significativo dell’alto-medioevo italico, finora in sottotraccia negli studi storici.
Downloads
Downloads
Pubblicato
Come citare
Fascicolo
Sezione
Licenza
RM Rivista pubblica in internet, ad accesso aperto, con licenza:
| CCPL Creative Commons Attribuzione |
L'autore conserva il copyright sul suo contributo, consentendo tuttavia a chiunque "di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare l'opera", purché siano correttamente citati l'autore e il titolo della rivista. L’autore, al momento della proposta di pubblicazione, è inoltre tenuto a dichiarare che il contenuto e l’organizzazione dell’opera è originale e non compromette in alcun modo i diritti di terzi, né gli obblighi connessi alla salvaguardia di diritti morali ed economici di altri autori o di altri aventi diritto, sia per testi, immagini, foto, tabelle, sia per altre parti di cui il contributo può essere composto. L’autore dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali per l’ipotesi di falsità in atti ed uso di atti falsi, e che pertanto Reti Medievali è esente da qualsiasi responsabilità di qualsivoglia natura, civile, amministrativa o penale, e sarà dall'autore tenuta indenne da qualsiasi richiesta o rivendicazione da parte di terzi.