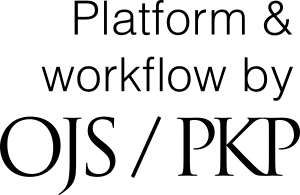Mercato e mercanti a Cava nel XV secolo
DOI:
https://doi.org/10.6093/1590-7937/9669Palabras clave:
Mercanti, Regno di Napoli, Sec. XV, Centro e periferia, IstituzioniResumen
Durante la dominazione angioino-aragonese nel Mezzogiorno d’Italia (secc. XIII-XV), poche città erano demaniali e, dal 1394, Cava faceva di parte queste nonostante mantenesse una connotazione alquanto ibrida causata dalla presenza di due tipi di autorità: regia e feudale. Il contesto politico-istituzionale fa da sfondo al seguente interrogativo: Cava era una città di mercanti o si trattava piuttosto di un luogo di mercato che accoglieva mercanti provenienti da diverse parti d’Italia e d’Europa? Partendo da tale quesito e adoperando una varietà di fonti non del tutto convenzionali per questa tipologia di indagine, il presente articolo vuole aprire una riflessione circa il profilo economico della città e dei sui cittadini durante il tardo medioevo.
Descargas
Citas
Cava de’ Tirreni, Biblioteca comunale “Canonico Aniello Avallone”, Archivio storico comunale, Costantino Grimaldi, Ms., a. 1690.
G. Abignente, Gli statuti inediti di Cava dei Tirreni, I-II, Roma 1886.
D. Alfano, Pragmaticae edicta decreta interdicta regiaeque sanctiones Regni Neapolitani, I-II, Napoli, Antonio Cervoni, 1772.
T. Avallone, Le «Carte» di G. Senatore, in «Appunti per la storia di Cava», VII (1992), pp. 89-92.
O. Beltrano, Breve Descrittione del Regno di Napoli, Napoli, appresso Roberto Mollo, 1644.
G. Bova, Il regesto dell’abate Golferio (1368), in «Benedictina», XXIII (1976), pp. 15-63.
G. Bova, I frammenti 17/1 arca XI e 17/11 arca XI dell’archivio cavense. Contributo alla ricostruzione de «II regesto dell’abate Golferio», in «Benedictina», XXV (1978), pp. 143-146.
G. Capriolo, Pratiche redazionali nel Regno di Napoli in età aragonese: realtà territoriali a confronto, in «Scrineum», XIV (2017), pp. 501-530.
C. Carleo, Regesti. Repertorio delle pergamene dell’Archivio Cavense. Periodo aragonese e principato del Viceregno:1443-1515, Cava de’ Tirreni (SA) 2015.
C. Carucci, Un comune del nostro Mezzogiorno nel Medioevo (Salerno XIII-XIV), Subiaco 1945.
P. Dalena, Passi, porti e dogane marittime. Dagli angioini agli aragonesi. Le lictere passus (1458-1469), Napoli 2007.
M. Del Treppo, Il re e il banchiere. Strumenti e processi di razionalizzazione dello stato aragonese di Napoli, in Spazio, società, potere nell’Italia dei Comuni, a cura di G. Rossetti, Napoli 1986 (Europa mediterranea. Quaderni, 1), pp. 229-303.
G. Foscari, L’equilibrio politico nelle funzioni: Cava nella seconda metà del cinquecento, in «Rassegna Storica Salernitana», XXXIX (2003), pp. 129-145.
G. Filangieri, Documenti per la storia, le arti e le industrie delle provincie napoletane, V-VI, Napoli 1981.
T. Gaudiosi, Privilegii della fedelissima città della Cava conceduteli da’ cattolici re aragonesi, Napoli, 1674.
A. Grohmann, Le fiere del regno di Napoli in età aragonese, Napoli 1969.
P. Guillaume, Essai Historique sur l’Abbaye de Cava d’après des documents inédits, Cava de’ Tirreni 1877.
A. Leone, Profili economici della Campania aragonese, Napoli 1988.
J. Mazzoleni, Fonti Aragonesi, I-IV, Napoli 1957-1964.
S. Milano, La Città de la Cava e i suoi Sindaci: secc. XV-XX, Cava de’ Tirreni 1996.
G. Orlando, Storia di Nocera de’ Pagani, II, Napoli 1886.
G. Petralia, Sicilia e Mediterraneo nel Trecento, in Spazi economici e circuiti commerciali nel Mediterraneo del Trecento, a cura di B. Figliuolo, G. Petralia, P. Simbula, Amalfi (SA) 2017, pp. 1-16.
A. Polverino, Descrizione Istorica della Città fedelissima della Cava, Napoli, Domenico Roselli, 1716-1717.
R. Ragosta, Napoli, città della seta: produzione e mercato in età moderna, Roma 2009.
A.M. Ratti, Fondaco, in «Enciclopedia italiana Treccani», Roma 1932, consultato all’indirizzo <https://www.treccani.it/enciclopedia/fondaco_%28Enciclopedia-Italiana%29/> (4/10/2022).
I registri della Cancellaria Angioina, Ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli archivisti napoletani, VI, 1270-1271, Napoli 1954; IX, 1272-1273, Napoli 1957; XVII, 1275-1277, Napoli 1963; XXI, 1280-1281, XXII, 1279-1280, Napoli 1967; XXIV, 1280-1281, Napoli 1976.
A. Sacchetti, Dalle «Carte Pandolfini», in «Appunti per la storia di Cava», VII (1992), pp. 55-65.
E. Sakellariou, Southern Italy in the Late Middle Ages, Leiden 2012.
F. Senatore, La pergamena bianca, Napoli 2012.
F. Senatore, Sistema documentario, archivi ed identità cittadine nel Regno di Napoli durante l’antico regime, in «Archivi», X/1 (2015), pp. 33-74.
F. Senatore, Le scritture delle universitates meridionali. Produzione e conservazione, in Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell’Italia tardomedievale (XIV-XV secolo), a cura di I. Lazzarini, Firenze 2008 = «Reti medievali. Rivista», IX/1 (2008), pp. 1-33.
G. Senatore, Della patria di Gio. Battista Castaldo, Napoli 1887.
A. Silvestri, Il commercio a Salerno nella seconda metà del Quattrocento, Salerno 1952.
S. Tognetti, L’economia nel Regno di Napoli tra Quattrocento e Cinquecento. Riflessioni su una recente rilettura, in «Archivio Storico Italiano», CLXX/4 (2012), pp. 757-768.
P. Terenzi, L’Aquila nel Regno. I rapporti politici fra città e monarchia nel Mezzogiorno tardomedievale, Bologna 2015.
G. Vitolo, Il registro di Balsamo, decimo abate di Cava (1208-1232), in «Benedictina», XXI (1974), pp. 79-129.
C. Wickham, The Mediterranean around 800: On the Brink of the Second Trade Cycle, in «Dumbarton Oaks Papers», CVII, I (2004), pp. 161-174.
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Gli Autori che pubblicano su questa rivista accettano le seguenti condizioni:
a. Mantengono i diritti sulla loro opera e cedono alla Rivista il diritto di prima pubblicazione, rilasciata con Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale - CC BY 4.0 che permette "di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare l'opera", indicando la paternità intellettuale del contributo (citando correttamente l'autore e il titolo della rivista) e la prima pubblicazione sulla presente Rivista.
b. Possono aderire ad altri accordi di licenza non esclusiva per la distribuzione della versione dell'opera pubblicata (es. depositarla in un archivio istituzionale o pubblicarla in una monografia), a patto di indicare che la prima pubblicazione è avvenuta su questa Rivista.
c. Al momento della proposta di pubblicazione, sono tenuti a dichiarare che il contenuto e l’organizzazione dell’opera è originale e non compromette in alcun modo i diritti di terzi né gli obblighi connessi alla salvaguardia di diritti morali ed economici di altri autori o di altri aventi diritto, sia per testi, immagini, foto, tabelle sia per altre parti di cui il contributo può essere composto. L’Autore dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali per l’ipotesi di falsità in atti ed uso di atti falsi. Schola Salernitana - Annali è esente da qualsiasi responsabilità di qualsivoglia natura, civile, amministrativa o penale, e sarà dall'autore tenuta indenne da qualsiasi richiesta o rivendicazione da parte di terzi.