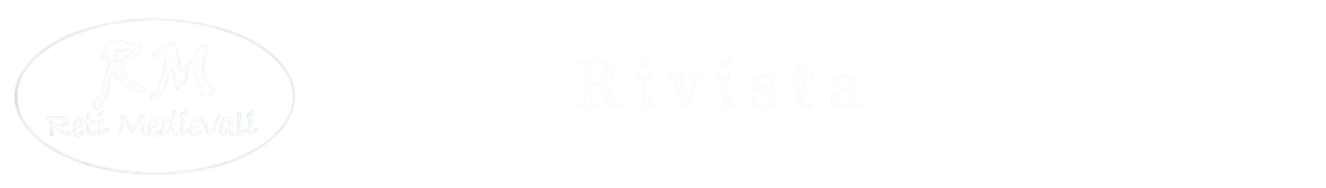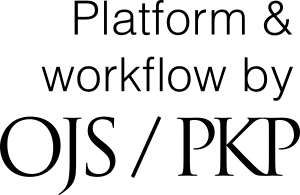L’economia della carità e del perdono. Questue e indulgenze nella Lombardia bassomedievale
DOI:
https://doi.org/10.6092/1593-2214/491Parole chiave:
Ospedali, indulgenze, elemosineAbstract
Nel basso medioevo, una delle modalità di sostegno a ospedali e confraternite era la raccolta organizzata di elemosine (questua), sempre più frequentemente legata alla concessione delle indulgenze. Il fedele acquisiva con la confessione il perdono dai peccati e con atti di devozione e carità (regolamentati da precise concessioni pontificie o vescovili) la riduzione della pena che avrebbe dovuto subire nell’aldilà (nel Purgatorio). Sebbene gli studi in ambito caritativo-assistenziale siano ancora abbastanza scarsi, non è fuor di luogo ipotizzare che proprio in tale contesto le indulgenze ebbero particolare fortuna. Le pagine che seguono intendono fornire elementi di riflessione per l’area lombarda, individuando anzitutto le pratiche attraverso le quali ospedali e confraternite potevano garantirsi i privilegi indulgenziali. Si è cercato poi, laddove le fonti lo consentivano, di quantificare, in termini di bilancio, i costi che l’ente doveva sostenere per la gestione di una campagna di indulgenze e i benefici economici che ne derivavano. Se relativamente ad alcuni ordini ospedalieri l’impatto economico delle questue pare essere rilevante, per altri casi esso appare marginale. È questo il caso dell’Ospedale Maggiore di Milano, che però, nonostante il ridotto impatto economico, riservò un ruolo importante alla “festa del Perdono”, a motivo del valore simbolico e comunicativo del proprio impegno a favore dei poveri che, nel contesto della carità e dell’assistenza, era altrettanto rilevante dell’aiuto materiale.Downloads
Downloads
Pubblicato
Come citare
Fascicolo
Sezione
Licenza
RM Rivista pubblica in internet, ad accesso aperto, con licenza:
| CCPL Creative Commons Attribuzione |
L'autore conserva il copyright sul suo contributo, consentendo tuttavia a chiunque "di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare l'opera", purché siano correttamente citati l'autore e il titolo della rivista. L’autore, al momento della proposta di pubblicazione, è inoltre tenuto a dichiarare che il contenuto e l’organizzazione dell’opera è originale e non compromette in alcun modo i diritti di terzi, né gli obblighi connessi alla salvaguardia di diritti morali ed economici di altri autori o di altri aventi diritto, sia per testi, immagini, foto, tabelle, sia per altre parti di cui il contributo può essere composto. L’autore dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali per l’ipotesi di falsità in atti ed uso di atti falsi, e che pertanto Reti Medievali è esente da qualsiasi responsabilità di qualsivoglia natura, civile, amministrativa o penale, e sarà dall'autore tenuta indenne da qualsiasi richiesta o rivendicazione da parte di terzi.