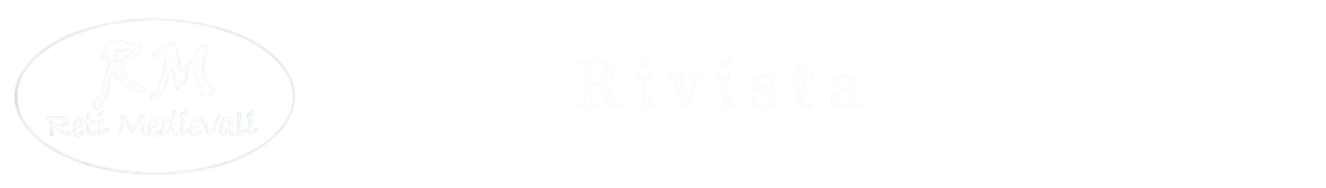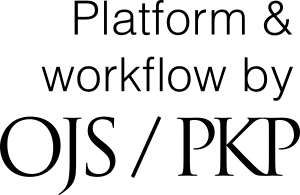Fines, termini et limites. I confini nella formazione dello Stato fiorentino
DOI:
https://doi.org/10.6092/1593-2214/164Parole chiave:
Medioevo, XIII-XIV Secolo, Toscana, Firenze, Stato, Comunità rurali, Territorio, ConfiniAbstract
I confini nella formazione dello Stato fiorentino. Nel processo di crescita e di maturazione dello Stato fiorentino, a partire almeno dalla fine del XIII secolo, l’attenzione nei confronti dei confini andò sempre più realizzandosi attraverso l’accentuazione dei caratteri di linearità delle demarcazioni, in netto contrasto con la dimensione zonale degli spazi confinari: per questo, laddove possibile, i confini sarebbero stati identificati con un tracciato stradale. Firenze andò affermando i limiti del proprio dominio con le altre realtà giurisdizionali, istituzionali e politiche circostanti, giungendo a ricercarne una legittimazione poi tradotta con precisione sul terreno e possibilmente concertata, come dimostrano i due accordi trecenteschi tra Firenze e il Comune bolognese qui presi in considerazione. La linea di condotta adottata dal Comune fiorentino in materia di tracciamento delle linee di confine con l’esterno sembra essere applicata come metodo anche all’interno del comitatus cittadino. Qui, l’espansione comunale aveva infatti lasciato pressoché intatte le ripartizioni territoriali preesistenti (comuni, plebati, ecc.) adeguandovi le esigenze istituzionali, amministrative, giurisdizionali comunali: sostanzialmente un disegno che doveva essere preservato e migliorato. Così, sempre più spesso – come nel caso del 1338 concernente due comunità vicine a Firenze qui illustrate – una precisa terminazione tracciata sul territorio si traduceva non solo nel tentativo di cancellare localmente un contenzioso tra universitates limitanee, ma anche in una garanzia per lo stabile assetto dell’intera organizzazione territoriale fiorentina.Downloads
Downloads
Pubblicato
Come citare
Fascicolo
Sezione
Licenza
RM Rivista pubblica in internet, ad accesso aperto, con licenza:
| CCPL Creative Commons Attribuzione |
L'autore conserva il copyright sul suo contributo, consentendo tuttavia a chiunque "di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare l'opera", purché siano correttamente citati l'autore e il titolo della rivista. L’autore, al momento della proposta di pubblicazione, è inoltre tenuto a dichiarare che il contenuto e l’organizzazione dell’opera è originale e non compromette in alcun modo i diritti di terzi, né gli obblighi connessi alla salvaguardia di diritti morali ed economici di altri autori o di altri aventi diritto, sia per testi, immagini, foto, tabelle, sia per altre parti di cui il contributo può essere composto. L’autore dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali per l’ipotesi di falsità in atti ed uso di atti falsi, e che pertanto Reti Medievali è esente da qualsiasi responsabilità di qualsivoglia natura, civile, amministrativa o penale, e sarà dall'autore tenuta indenne da qualsiasi richiesta o rivendicazione da parte di terzi.