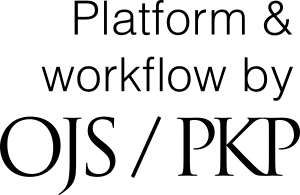[chiusa] Gli immaginari socio-tecnici delle transizioni energetiche e della giustizia ambientale.
Guest editors:
Federica Viganò, Libera Università di Bolzano, federica.vigano@unibz.it
Monica Musolino, Università di Messina, mmusolino@unime.it
Elisabetta Bucolo, Conservatoire National des Arts et métiers-Cnam/LISE-CNRS di Parigi, elisabetta.bucolo@lecnam.net
La call si intende stimolare un dibattito critico sugli immaginari socio-tecnici che accompagnano e orientano la transizione energetica (da ora in avanti TE), connotandone le pratiche collettive e individuali, così come le politiche pubbliche su diverse scale (globale, europeo, nazionale e locale). Infatti, gli immaginari tecnocratici, imperniati sul ruolo centrale e prioritario dell’innovazione tecnologica, si sono affermati come narrazione dominante in vari ambiti del sapere e della condivisione e trasmissione della conoscenza (Pellizzoni, 2011, Fisher, 2009, Jasanoff, 2003).
Il discorso tecnico-scientifico ha prodotto degli immaginari caratterizzati da una forte normatività e dall’avversità verso approcci non allineati (per esempio il punto di vista di popolazioni emarginate e portatrici di una conoscenza locale o di gruppi più deboli) che finisce per depoliticizzare la questione ecologica. Questo configura i termini della questione della giustizia ambientale ed epistemica (Drique, Lejeune, 2017, Fricker, 2023, 2007). Infatti, le condizioni strutturali creano ingiustizia dal punto di vista socioeconomico e i gruppi che ne risultano maggiormente svantaggiati risultano essere anche quelli sui quali ricadono i costi più alti della crisi climatica (Rosignoli, 2020 ; Martinez Alier, 2014). Ad una condizione di doppia esclusione, si aggiungono gli effetti delle politiche pubbliche, le quali si costruiscono attorno alle esigenze e alla disponibilità di risorse dei gruppi sociali più avvantaggiati, marginalizzando ulteriormente le popolazioni più vulnerabili. Queste ultime diventano oggetto di un doppio misconoscimento: non vengono legittimate come attori della transizione ecologica e i loro saperi non sono riconosciuti come saperi esperti delle questioni ecologiche che li riguardano, ma piuttosto sono invisibilizzati dal sapere e dalle narrazioni dominanti (Bucolo, 2024 ; Godrie, Dos Santos, 2017).
Inoltre è rilevante osservare che la produzione di retoriche incalzanti di tipo tecnocentrico sono spesso legate alla nozione di “urgenza”: molti enti governativi e organizzazioni internazionali promuovono la tecnologia come soluzione principale per il raggiungimento di obiettivi temporali che spesso non considerano la componente umana, le azioni collettive e i comportamenti individuali si relazionano in modo complesso e culturalmente situato all’applicazione delle innovazioni tecnologiche, rendendo così problematiche le suddette rappresentazioni semplificatrici.
Un aspetto rilevante della prospettiva critica che si vuole sollecitare con la presente call riguarda il riconoscimento del fatto che gli immaginari sulla TE possono essere espressione di una molteplicità di attori: i governi, la componente di S&T (Scienza e tecnologia), l’università, le imprese private, la società civile. A tal proposito, il paradigma co-produzionista (Chilvers et al., 2021, 2018, Chilvers, Kearnes, 2020) si è di recente imposto all’interno degli STS, sottolineando l’importanza di allineare i diversi soggetti all’interno di processi decisionali sulla TE per costruire una prospettiva contro-egemonica al paradigma dominante. Le esperienze di partecipazione civile sui temi del clima o della TE sono un segnale importante della consapevolezza che la TE non è prevalentemente di tipo tecnico-normativo. Numerose organizzazioni della società civile contestano la governance imposta dall’immaginario socio-tecnico proponendo prospettive e pratiche alternative che valorizzano la giustizia sociale, la partecipazione democratica e la sostenibilità ecologica: dai gruppi che fanno opera di denuncia dell’attuale status quo delle élite tecnocratiche ed economiche, a iniziative locali alternative basate su conoscenze tradizionali e pratiche sostenibili, per rafforzare la resilienza delle comunità e degli ecosistemi naturali, per arrivare ai movimenti più radicali di disobbedienza civile.
La call invita contributi di carattere teorico o empirico sulle seguenti tematiche:
- Possibili combinazioni o prevalenze dei fattori che possono portare ad un cambiamento sistemico sulla TE: capacità di agire incorporata nei diversi attori, giustizia, potere, ruolo della politica e delle policies, rappresentazioni degli immaginari, coinvolgimento e governance.
- Immaginari socio-tecnici locali di popolazioni indigene o locali che attribuiscono i propri significati alle strategie di TE centrate sull’innovazione tecnologica legata all’uso di fonti energetiche rinnovabili, contrapponendo i propri saperi e le proprie pratiche ecologiche.
- Immaginari socio-tecnici dotati di una forte connotazione politica, come avviene, ad esempio quando popolazioni locali ribaltano l’approccio sussuntivo che orienta la costruzione di impianti massivi facendone uno strumento di emancipazione o autonomia politica sul piano narrativo.
- Incrocio fra ingiustizia ambientale e ingiustizia epistemica con riferimento al modo in cui si elaborano le politiche pubbliche della TE nei confronti di tali pratiche e saperi.