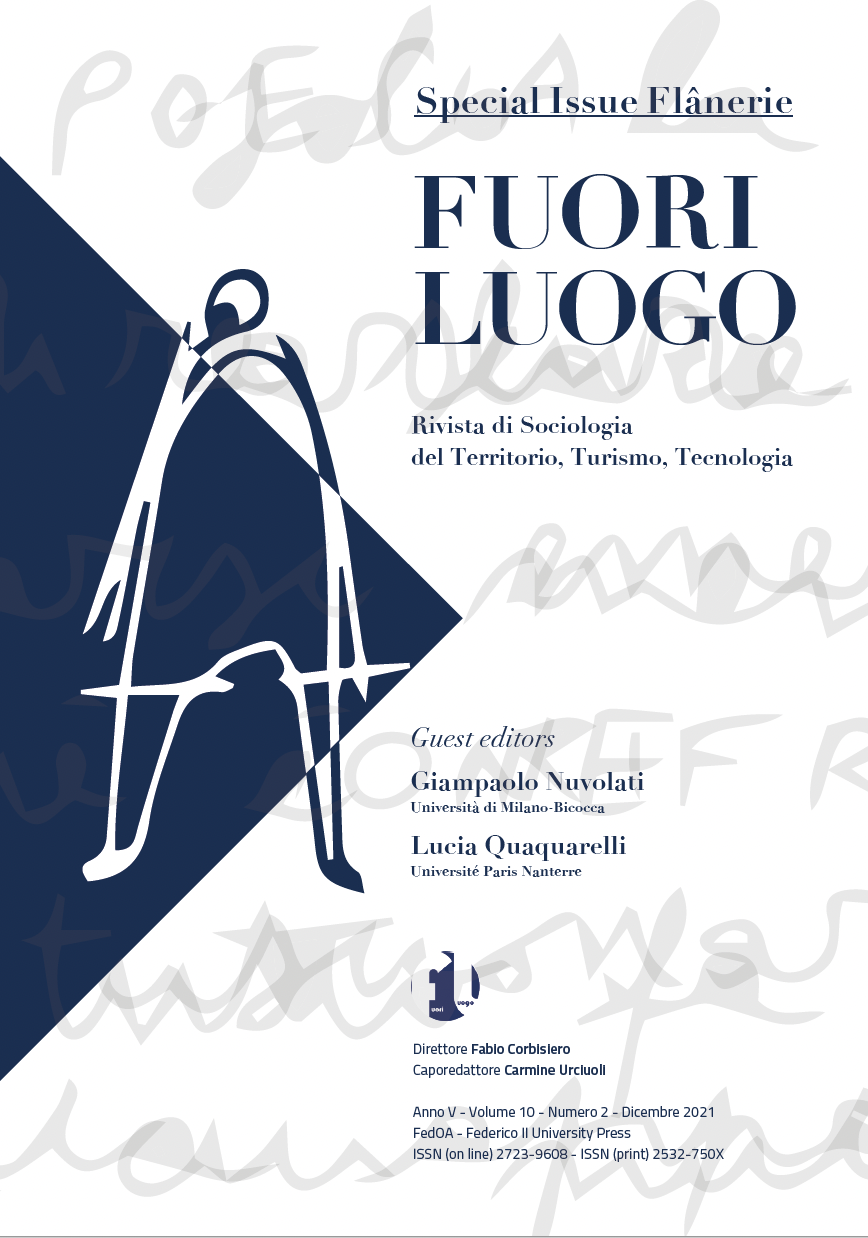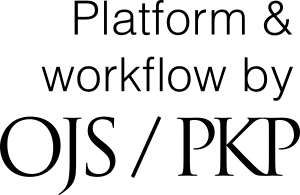Breve storia delle fantasmagorie
DOI:
https://doi.org/10.6093/2723-9608/8073Parole chiave:
Flâneur, fantasmagoria, iperrealtà, simulacra, retail esperienzialeAbstract
L’articolo evidenzia il legame tra il flâneur, come descritto negli studi di Benjamin, e i luoghi emblematici della moderna società dei consumi, incentrati sul valore simbolico della merce. In primo luogo viene chiarito il significato filosofico della parola “fantasmagoria”, la sua origine e l’uso, in particolare riferimento alla tradizione critica marxista che va da Adorno fino ai più recenti lavori di Andreotti e Lahiji. In seguito vengono indagate le origini del flâneur nella Parigi ottocentesca, sottolineando il rapporto tra il personaggio del libero passeggiatore nella metropoli e la tradizione letteraria, l’estetica e lo stile di vita che definiscono la modernità. Nella parte centrale del saggio sono prese in esame le tappe che hanno marcato la storia delle fantasmagorie, considerando l’evoluzione delle tecnologie e della tipologia di esperienze offerte al consumatore: i passages parigini, la metropoli moderna, i grandi magazzini, le esposizioni universali, i centri commerciali, i parchi a tema, i “superluoghi” e, infine, gli spazi dell’architettura virtuale. Saranno messe in luce in particolare le tendenze attuali dello shopping esperienziale e dell’omnichannel, per dimostrare l’impatto della tecnologia mediatica sulla fruizione degli spazi del consumo, reali e virtuali. Le ipotesi che si cerca di dimostrare sono dunque le seguenti: 1. La continuità storica tra modernità europea del XIX secolo e mondo contemporaneo. 2. La centralità del flâneur nella scena urbana, inteso come osservatore e fruitore dello spettacolo della metropoli e dell’esperienza estetica che essa offre. 3. L’importanza del rituale dello shopping, attività che pare sopperire a un bisogno fondamentale dell’uomo di oggi.